lunedì 7 luglio 2025
Di Avv. Gianni Dell’Aiuto
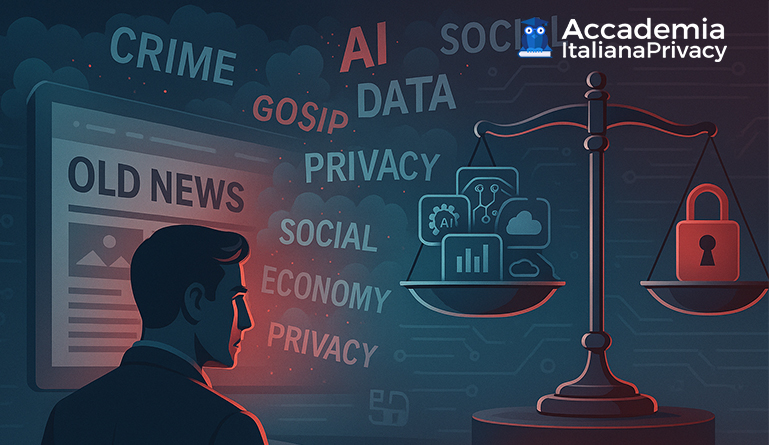
Non è più il tempo in cui ci si limitava a chiedere la rimozione di un link da Google per un vecchio articolo di cronaca o una disavventura giudiziaria superata.
Il diritto all’oblio non basta più
Il diritto all’oblio, così come lo abbiamo conosciuto dalla storica sentenza Google Spain (CGUE, 13 maggio 2014), oggi si ritrova a inseguire una nuova minaccia: quella degli algoritmi che, senza intenti malevoli, riportano in superficie contenuti sorpassati, estrapolati dal contesto e rimontati secondo logiche di engagement, previsione o “interesse simile”.
Potrebbe interessarti > Tra cronaca, informazione e diritto all'oblio
Non è più il giornalista, né il motore di ricerca umano, a selezionare cosa meriti di restare visibile. È il sistema. Ed è qui che il diritto all’oblio diventa diritto alla contestualizzazione. Perché un’informazione vera, legittimamente trattata, può diventare ingannevole semplicemente per effetto del tempo, dell’automazione e dell’assenza di filtri umani nel riproporla.
Immaginiamo un caso reale: un soggetto coinvolto dieci anni fa in un procedimento penale, poi archiviato. Un algoritmo AI di un portale di news, basato su preferenze di lettura o su correlazioni tra parole chiave, può mostrare ancora oggi quell’articolo come “notizia collegata” a temi di criminalità o economia, nonostante l’esito favorevole. Nessun intento diffamatorio, nessun trattamento illecito di per sé. Ma l’effetto finale è lo stesso: disinformazione, discredito, pregiudizio. E in alcuni casi, danno patrimoniale.
Il GDPR, all’articolo 17, riconosce il diritto alla cancellazione dei dati personali in una serie di ipotesi. Tra queste: quando il trattamento non è più necessario, quando l’interessato revoca il consenso, o quando si oppone per motivi legittimi. Ma il Regolamento non aveva ancora fatto i conti con un mondo in cui la “persistenza” dei dati non è sempre imputabile a un titolare specifico, bensì alla combinazione di sistemi che li ripropongono.
Il punto critico sta nel fatto che gli algoritmi non distinguono tra dati attuali e superati, tra interesse pubblico e gossip d'archivio, tra cronaca e pregiudizio. E, ancora più grave, non esiste una norma che imponga di aggiornare, segnalare o ridimensionare l’informazione secondo criteri di rilevanza temporale. La normativa è ferma al principio, la tecnologia si muove sulla probabilità.
Chi risponde, dunque, del danno causato da un’informazione riproposta automaticamente? Il titolare originario? Il fornitore dell’algoritmo? La piattaforma che aggrega contenuti? Il problema non è ancora normativamente risolto. Le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati affrontano l’oblio principalmente nei confronti dei motori di ricerca, ma tacciono su quanto accade nei feed social, nei suggerimenti delle piattaforme AI e nei motori di raccomandazione delle testate online.
Il vuoto non è solo giuridico, è concettuale. La Corte di Giustizia ha iniziato a spingersi oltre, con la sentenza del dicembre 2022 (C-460/20), affermando che anche nei casi di diritto all’oblio deve esserci un bilanciamento tra il diritto alla privacy e la libertà di espressione, ma resta silente su chi debba operare quel bilanciamento in ambito algoritmico.
Conclusioni
Alcune proposte operative iniziano a circolare: watermark temporali nei contenuti, sistemi di aggiornamento automatico della datazione, avvisi di contestualizzazione simili a quelli usati in caso di fake news. Ma manca ancora un modello normativo condiviso. Introdurre un principio di “rilevanza temporale” nel trattamento dei dati pubblici sarebbe un primo passo, così come rendere trasparenti i criteri algoritmici di selezione e proposta dei contenuti.
Il diritto all’oblio, in questa nuova fase, non è più solo il diritto a sparire. È il diritto a non essere esposti di nuovo, per automatismo, in assenza di verità attuale. È il diritto a non essere definito oggi da ciò che ieri era già stato superato. Il diritto all’oblio algoritmico non cancella la memoria. La riordina. E ricorda a chi sviluppa le tecnologie che i dati non sono parole inerti, ma identità in divenire.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
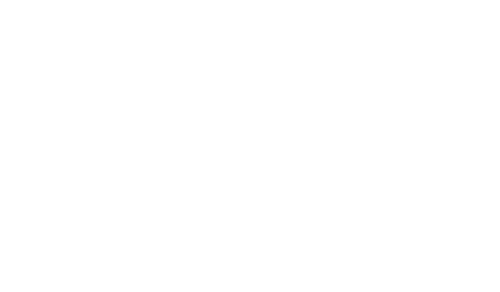 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!