giovedì 13 novembre 2025
di Avv. Gianni Dell'Aiuto

Quando parliamo di privacy, pensiamo che sia un’invenzione recente, nata per difendere l’individuo da internet, dalla pubblicità, dalla sorveglianza di massa. Ma la riflessione sul confine tra ciò che deve essere detto e ciò che deve restare taciuto è antica quanto l’uomo stesso. Prima che esistesse la parola “privacy”, esisteva l’idea di riservatezza. E prima ancora della legge, esisteva la virtù del silenzio.
Dalla virtù del silenzio all'anticipazione della riservatezza
Già nel mondo classico, filosofi e retori avevano intuito che il potere della parola andava dosato, non ostentato. Socrate ammoniva che “parlare molto di sé non è mai segno di equilibrio”, mentre Seneca, nelle sue Lettere a Lucilio, distingueva tra la parola che illumina e quella che espone inutilmente. Persino Tacito, storico del potere, riconosceva che nelle corti imperiali la sopravvivenza dipendeva più dal tacere che dal parlare. Tacere era una forma di prudenza e di libertà insieme.
Nel Medioevo, il valore del silenzio divenne una regola morale e religiosa. I monaci benedettini lo inserirono nella loro Regula, affermando che il silenzio è il primo passo della saggezza. Nelle celle dei monasteri il tacere non era solo rinuncia al mondo, ma rispetto per la coscienza altrui: un modo per mantenere intatto lo spazio interiore. In un certo senso, era già un’anticipazione della “zona privata” che le moderne Costituzioni cercheranno di tutelare.
Joseph Dinouart: la filosofia della riservatezza nel secolo dei Lumi
Arriviamo così al Settecento. È in questo secolo, attraversato dall’Illuminismo e dalla nascita della sfera pubblica borghese, che la riflessione sulla parola e sul silenzio assume un tono laico. È qui che interviene l’abate Joseph Antoine Dinouart, con il suo trattato "L’art de se taire" o L’arte di tacere (1771). L’opera, scritta in un francese sobrio e lucidissimo, non è un esercizio di retorica ma una vera filosofia della riservatezza. Dinouart non parla di “privacy” perché il termine ancora non esiste, ma ne descrive con precisione l’essenza morale. Per l’abate, tacere non è vigliaccheria ma controllo. È la scelta consapevole di non esporsi inutilmente al giudizio del mondo. Scrive che l’uomo che sa tacere “possiede se stesso” e che “parlare troppo è una forma di dispersione”.
In quelle frasi, pronunciate due secoli prima della nascita di quello che noi conosciamo come diritto alla privacy, c’è già tutto: la discrezione come virtù, il rispetto del confine tra sé e gli altri, la consapevolezza che la parola è un rischio. Dinouart, in fondo, anticipa l’idea che ciò che si dice può essere usato contro di noi e che il controllo su ciò che esponiamo di noi stessi è una forma di libertà.
Il suo pensiero si inserisce nella tradizione morale del secolo dei lumi, ma ha una modernità sorprendente. Per Dinouart, chi comunica senza misura non è libero ma schiavo del bisogno di essere ascoltato. E chi confida tutto a chiunque si espone alla manipolazione. È una visione che oggi potremmo tradurre nei termini di data minimization: meno si diffonde, meno si rischia.
Dal diritto di tacere all'articolo sul Diritto alla Privacy (GDPR)
Un secolo dopo, nel 1890, Samuel Warren e Louis Brandeis trasformano quell’intuizione in un principio giuridico. Nel celebre articolo "The Right to Privacy", pubblicato sulla Harvard Law Review, definiscono la privacy come “il diritto di essere lasciati soli”. O, forse, più esattamente, in pace. È la risposta alla nascente stampa scandalistica e alla diffusione della fotografia, le prime tecnologie capaci di invadere la vita privata senza consenso. Warren e Brandeis, tuttavia, non inventano nulla di nuovo: traducono in linguaggio legale ciò che Dinouart aveva già intuito in linguaggio morale.
Nel Novecento, il pensiero sulla privacy si intreccia con quello dei diritti umani e dell’etica della comunicazione. Dopo la Seconda guerra mondiale, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) riconosce il diritto di ogni individuo “a non subire interferenze arbitrarie nella sua vita privata”. È la prima consacrazione globale di un concetto che, in fondo, nasceva da una regola spirituale: saper tacere.
Per chi lavora oggi nella protezione dei dati, rileggere Dinouart non è un esercizio letterario, ma un ritorno alle origini. Il GDPR, con i suoi principi di proporzionalità, necessità e limitazione, non fa che tradurre in linguaggio normativo quella stessa saggezza. “Non tutto ciò che si può dire, deve essere detto”: Dinouart l’avrebbe sottoscritto, e forse l’avrebbe aggiunto all’articolo 5 del Regolamento europeo. Ecco perché l’abate francese può essere considerato il primo vero teorico della privacy ante litteram. Non scrisse di sistemi informativi, ma di coscienza. Non parlò di archivi o banche dati, ma del valore di ciò che resta non detto. Oggi che la comunicazione è eccesso, che il silenzio fa paura e che la trasparenza è diventata obbligo, la sua voce risuona più attuale che mai.
Perché la riservatezza, prima di essere una norma, è una scelta morale. E chi sa tacere, ieri come oggi, non perde nulla: semplicemente conserva ciò che non vuole consegnare al mondo.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
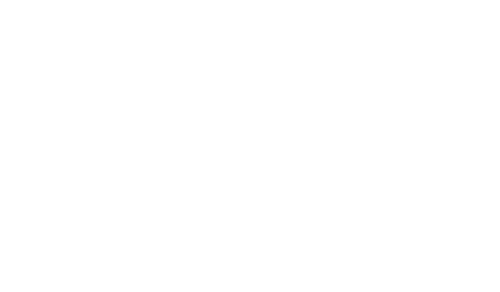 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!