giovedì 10 luglio 2025
Di Avv. Gianni Dell’Aiuto
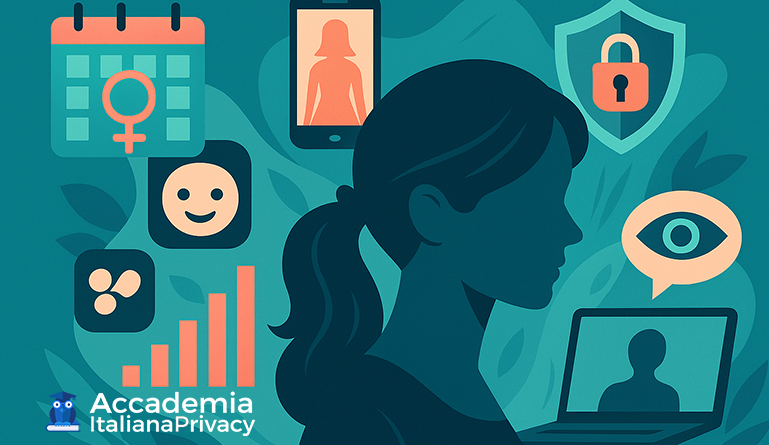
Chi vuole affrontare il tema della privacy femminile con onestà intellettuale deve partire da un presupposto: non si tratta di proteggere una categoria fragile, ma di osservare come, in certi ambiti, le donne siano più e diversamente esposte. Più visibili, più profilate, più ascoltate dagli algoritmi. E, di conseguenza, più vulnerabili. Non per struttura genetica o per debolezza di carattere, ma per collocazione pratica nel mercato della società digitale.
La privacy femminile nell’era digitale: tra sovraesposizione e vulnerabilità
Esistono app che registrano il ciclo mestruale, suggeriscono i giorni fertili, tracciano sbalzi d'umore e consigliano prodotti per la pelle. Sono utilizzate da milioni di donne. Quelle app, lo sappiamo bene, si finanziano attraverso la cessione di dati. Una volta si chiamava profilazione commerciale, oggi è parte dell'economia dell’intimità. Dati sanitari, sessuali e psicologici raccolti con una leggerezza formale che il GDPR non ha del tutto domato, e con una superficialità d’uso da parte dell’utente che va ben oltre ogni informativa.
Approfondisci > La nostra salute regalata alla rete
Potrebbe interessarti > Fitness Tracker: il prezzo della nostra Privacy tra salute e tecnologia
Questo non accade perché le donne sono ingenue, ma perché le piattaforme sono intelligenti. E quando il confine tra autoanalisi e autosfruttamento si assottiglia, il problema non è chi si racconta, ma chi registra. E magari cercano conforto o informazioni in momenti in cui possono essere maggiormente fragili.
Nel mondo del lavoro la questione assume altre forme. Durante colloqui, stage o periodi di prova, le domande sulla maternità, sulla disponibilità al part-time, sulla gestione familiare sono ancora presenti. A volte esplicite, più spesso insinuate. Qui la violazione della privacy è doppia: formale, perché non c’è titolo per trattare quei dati; sostanziale, perché si utilizzano informazioni sensibili per escludere. Le donne che lavorano lo sanno bene: il dato è sempre personale, ma raramente neutro.
Poi c’è il privato, che oggi è la vera zona grigia. Smartphone condivisi in famiglia, password lasciate in sospeso, app collegate tra partner. Quando una relazione finisce, la traccia digitale resta. E viene usata. Il caso estremo è quello del revenge porn, ma prima di arrivarci esiste tutta una zona quotidiana di controllo, gelosia digitale, microspionaggio fatto di notifiche, localizzazioni e letture invisibili. La tecnologia che doveva unire diventa strumento di sorveglianza domestica. Non serve inventarsi un nuovo femminismo, basta applicare il Codice penale e il GDPR.
Anche sui social la partita è aperta. La sovraesposizione non è solo una scelta personale. È anche una pressione. Le influencer raccontano il corpo, la vita, la casa, i figli, le diete, le crisi di coppia. Ma se chiunque è potenzialmente visibile, allora ogni donna diventa anche un potenziale bersaglio. Di giudizi, di richieste, di modelli. Ed ecco che si manifesta, in particolare per le giovanissime, la dismorfia da Snapchat. Ma il problema è più ampio: è l’illusione collettiva che il corpo debba adattarsi a un filtro, e che la bellezza sia una questione di algoritmo. È qui che la privacy smette di essere un diritto astratto e diventa una trincea quotidiana.
Anche la reputazione digitale segue lo stesso schema: non è solo difesa, è costruzione. Un errore, una frase mal interpretata, un’immagine fuori contesto possono diventare etichette indelebili. E quando capita a una donna, la società è più pronta a giudicare. Le conseguenze sono pratiche: un contatto perso, un’opportunità sfumata, un avanzamento bloccato. Non serve la retorica della discriminazione, basta guardare le statistiche sull’hate speech di genere.
Il punto è che la privacy femminile esiste, ma non come ambito separato o privilegiato. Esiste perché alcune situazioni creano una concentrazione più alta di dati delicati, esposti, vulnerabili. Esiste perché ci sono strumenti digitali che parlano più facilmente alle donne e poi usano quel dialogo per finalità che non vengono dichiarate. Esiste perché le immagini femminili sono più cliccate, più imitate e più giudicate.
Conclusioni
Parlare di privacy al femminile, dunque, non significa creare un recinto giuridico, ma accendere una luce su una realtà già presente. Una realtà dove il problema non è solo chi tratta i dati, ma anche chi li cede con leggerezza, chi li archivia senza sapere come, chi li diffonde per abitudine. Uomini o donne, poco cambia. Ma quando il corpo, le scelte personali o l’aspetto fisico diventano una voce nei sistemi informatici, allora è legittimo chiedersi se certi strumenti meritino tutta questa fiducia.
La tutela dei dati, in questi casi, non è una gentile concessione, ma una misura igienica. Come lavarsi le mani prima di cucinare. Non per educazione, ma per rispetto. Perché prima o poi, ogni dato è una persona. E ogni persona ha un margine di pudore che nemmeno l’Intelligenza Artificiale dovrebbe ignorare.
I 5 errori di compliance che le aziende continuano a fare (nonostante il Garante)
giovedì 8 gennaio 2026
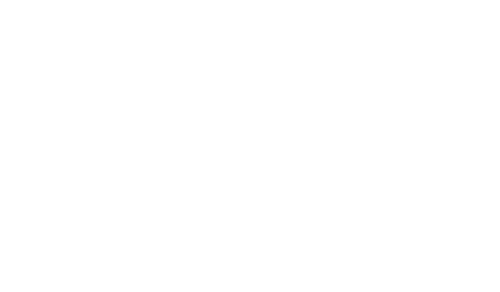 Leggi tutto...
Leggi tutto...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA!